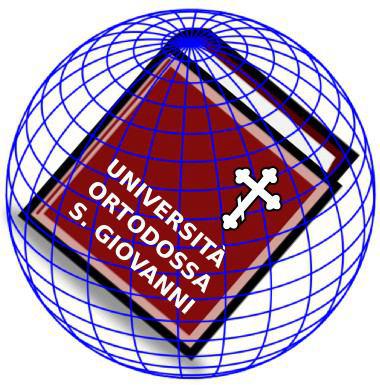Il “Padre Nostro”: le particolarità nell’ortodossia
Accade assai spesso che fedeli, esperti e studiosi di liturgia ci pongano la delicata questione delle specificità, nelle tradizioni ortodosse, che caratterizzano la recitazione del “Padre Nostro”, preghiera essenziale nella storia del Cristianesimo, sia d’Occidente che d’Oriente, presente già nel II - III secolo nella forma aramaica (con la denominazione “Abùn”, padre, tratta dai versi iniziali “Abùn D - bah - Smaja”, “Padre che sei nei cieli”) e transitato in forma molto simile nella forma ebraica (Abun, “Padre”), poi in quella greca (con la denominazione “Kiriake Proseukè”: preghiera del Signore) e poi nella traduzione latina della “Vulgata” di San Gerolamo, che inizia a diffondersi dal IV secolo (quando la preghiera assume la denominazione di “Oratio Dominica”).
Anche se non mancano, in Italia, parrocchie e gruppi di fedeli ortodossi che recitano ormai il Padre Nostro in forma uguale a quella consolidatasi nel rito cattolico romano che tutti conoscono - prassi non sempre condivisibile - giova ricordare a coloro che intendono invece approfondire le differenze che nel mondo ortodosso sono maggiormente diffuse e salvaguardare le identità della formulazione orientale, le tre principali differenze nel testo liturgico da recitare, precisando che le prime due sono meno seguite, specialmente nel nostro Paese, mentre la terza è più rispettata, anche nelle parrocchie di tradizione russa e rumena.
1.Il pane “quotidiano”
Nella tradizione ortodossa, è assai diffusa e sarebbe senz’altro sempre preferibile la forma “Dacci oggi il nostro pane soprasostanziale” o “necessario”. Tale espressione traduce, in modo molto più appropriato, la formulazione greca “Tòn àrton hemòn tòn epiùsion dòs hemìn sémeron” (dove “epiùsion” è tradotto in latino dalla Vulgata “ supersubstantialem”). Ricordiamo che la radice ”ousian” (qui col prefisso “epì”, sopra) è di particolare importanza nella filosofia, nella teologia e nell’esegesi, identificando l’ “ousia” la sostanza, l’essenza profonda, ciò che è in sè sussistente.
2.“Non ci indurre in tentazione”
La formulazione venuta cristalizzandosi nella tradizione latina appare poco rispondente all’originaria stesura greca, in cui il verso completo è: “kài mé eisenènkes hemàs eis peirasmòn (presente in Matteo 6,13 e Luca 11,4, e discutibilmente tradotta nel latino “ne nos inducas in tentationem”). Il verbo utilizzato eisphérein significa letteralmente “portare / condurre verso “, diverso e meno “forte” di "inducere" (il vero “calco” latino - come nota il prof. R. Uglione, che sul versetto in questione ha condotto encomiabili approfondimenti filologici, sarebbe difatti "inferre") della Vulgata (per la verità "inducere" non si deve alla traduzione di S. Girolamo ma è già ampiamente attestato nelle versioni Veteres Latinae pregeronimiane, come il cod. Bobbiensis e il cod. Colbertinus) ad attenuare il significato del versetto meglio traducendo, come spesso fanno le tradizioni ortodosse, con formule come “non permettere che noi siamo indotti in tentazione”. Ricordiamo che il testo nell’aramaico originario era w-là, “e non”, tà-làn, “portarci, portare noi”, l - nesjuhnàh “in tentazione”). Persino sant’Ambrogio (già nel 370-380!) insegnava ai catecumeni “et ne nos patiaris induci in temptationem” (“e non tollerare che siamo indotti in tentazione” - Trattato De Sacramentis V 4,18). Su questa linea esegetica modificatrice si colloca una buona parte della tradizione patristica e anche una nuova e recentissima traduzione Cei della Bibbia: “e non abbandonarci alla tentazione”. I problemi non riguardano solo il verbo eispherein, dal momento che il greco peirasmós può significare “tentazione” ma anche, più semplicemente, “prova”. È chiaro che la scelta tra queste due accezioni implica due “agenti” diversi: la “prova” provenendo da Dio, la “tentazione” dal demonio. Da più parti ( anche autorevoli ) è stato fatto osservare che Dio, essendo Padre misericordioso, non può assolutamente mettere alla prova i suoi figli né tantomeno tentarli. Ciò sarebbe per alcuni addirittura blasfemo. Per la verità, alcuni episodi biblici parrebbero attestare il contrario (basti citare i casi di Abramo e di Giobbe, ed alcune inequivoche espressioni dei Salmi : Ps. 10, 5 “ Il Signore mette alla prova giusti ed empi”. Dal salmo 25, 2 si deduce che il giusto può persino chiedere a Dio di metterlo alla prova: “Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova”). Non solo, ma Dio può addirittura permettere a Satana di “tentare” il giusto: basti citare l’episodio notissimo delle tentazioni di Gesù nel deserto, prima dell’inizio della sua vita pubblica, e il bellissimo commento che ne fa S. Agostino (Comm. al Salmo 60,3) : “La nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove...Nessuno può conoscere sé stesso se non è tentato... Il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo mistico, nelle vicende del suo corpo reale... Dunque egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere tentato da Satana... Cristo fu tentato dal diavolo nel deserto, ma in Cristo eri tentato anche tu... Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato, ma perché non consideri che egli ha anche vinto ? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore!”. In definitiva, personalmente riterrei preferibile “non abbandonarci nella prova / nel momento della prova”, naturalmente anche nel senso ampio di “ non sottoporci, o Signore, ad una prova troppo dura e troppo pesante per le nostre forze” o, al limite, “ non abbandonarci nella tentazione / nel momento della tentazione” , in linea con S. Paolo (Prima lettera ai Corinzi, 10,13: “Dio ... non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere”. Singolare, che dopo ben diciassette secoli, solo negli anni scorsi si sia aperto, nel mondo teologico latino un dibattito articolato su questo argomento, certamente delicato ma assai interessante, e non solo sul piano storico e filologico.
3.“Liberaci dal Maligno”
Sono molto numerose ed ampiamente condivisibili le tradizioni ortodosse che utilizzano la formula “
Liberaci dal Maligno”, anziché “
Liberaci dal male”. Ricordiamo che il testo greco originario è “
allà rüsai hemàs apò tu poneroù” e quello aramaico nella prima formulazione era
èla pacàn mèn bisàh, “
ma liberaci da ciò che è male”. Anche alla luce di quanto esposto sopra rispetto alla traduzione “
Non abbandonarci nella tentazione”, sarebbe più coerente interpretare nel versetto seguente il genitivo
poneroû come un genitivo maschile (“
Maligno”) anziché neutro (“
male”), cioè, appunto, “
ma liberaci dal Maligno” (dal quale provengono le tentazioni). Questa posizione, per così dire, “personificatrice” è confortata dal fatto che in numerosi manoscritti greci (anche antichi) leggiamo, a conclusione del Padre nostro, la dossologia “
Poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli “ (versione - testo dell’
oratio Dominica inglobante la dossologia come parte integrante - adottata anche nell’eucologia e nella liturgia delle Chiese della Riforma). Come ricorda ancora Uglione, l’attestazione di una analoga dossologia già nella Didaché ( un’opera risalente alla fine del I secolo d. C.) fa ritenere che tale dossologia sia un ampliamento molto arcaico, dovuto quasi sicuramente a motivazioni liturgiche. Era, infatti, consuetudine diffusa nel giudaismo concludere le preghiere con una dossologia formale e le prime comunità cristiane erano solite seguire la prassi liturgica sinagogale. E’ evidente infatti, in prospettiva escatologica, che la potenza del Maligno è destinata, alla fine dei tempi, a svanire e ad essere superata e vinta dalla potenza di Dio: poiché, in definitiva, suoi e soltanto suoi sono il regno, la potenza e la gloria.
Mons. Max Giusio
Teologo - Vice Rettore della
Università Ortodossa San Giovanni Crisostomo